A Baghdad un vuoto pericoloso
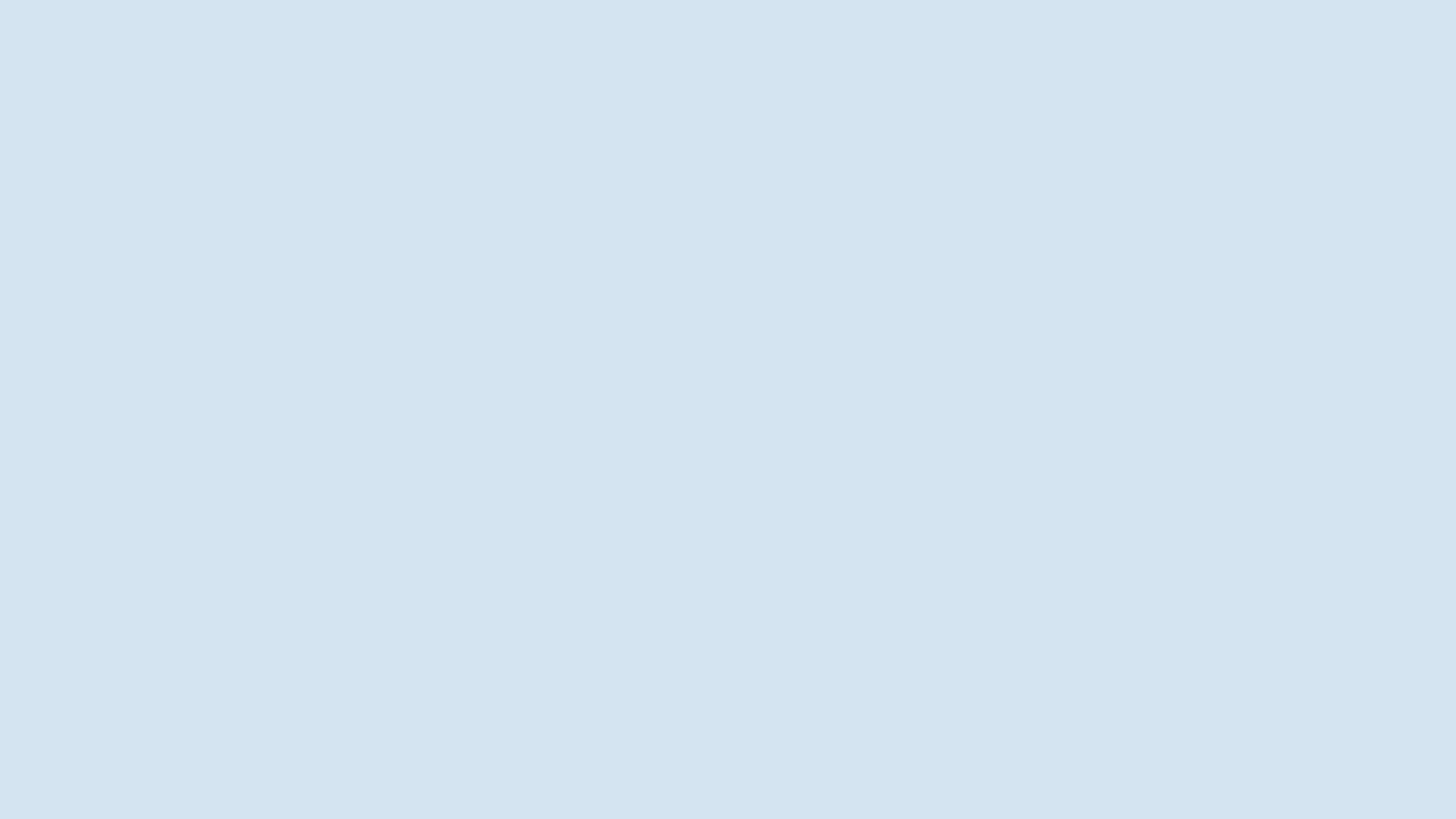
di GERARDO MORINA - Partenza discreta, quella avvenuta la settimana scorsa, delle truppe USA dall?Iraq. Sette anni e cinque mesi dopo l?intervento americano e la caduta di Saddam Hussein a Baghdad, il presidente Obama ha mantenuto la scadenza da lui promessa. Militari a casa (molti dirottati in Afghanistan), mentre in Iraq rimarranno 50 mila addestratori e 7.000 «contractor» privati che dovranno provvedere alla sicurezza delle aree petrolifere. Nessuno ha parlato, questa volta, di «missione compiuta», ma non tutto è negativo: va dato atto al generale Petraeus di avere offerto con la sua concentrazione e offensiva di truppe (il famoso «surge») perlomeno un?impalcatura ad un processo di «nation building», di edificazione nazionale, che in Iraq sta, anche se a stento, proseguendo. Gli americani sono inoltre riusciti a trasformare il popolo con cui hanno combattuto, gli iracheni, in loro alleato. Se possibile, il ritiro definitivo avverrà nel 2011, una data che potrebbe slittare a dipendenza delle circostanze. Non a caso «Stars and Stripes», giornale delle forze armate USA, ha usato come titolo «The long goodbye»: un lungo arrivederci, non un addio.Ma la partenza degli americani sta creando in Iraq un vuoto pericoloso, di cui molti potrebbero approfittare. C?è innanzi tutto una paralisi politica. Cinque mesi dopo le tanto celebrate elezioni, i due rivali Allawi e al-Maliki non sono riusciti a formare un governo e continuano a resistere ad ogni proposta di coalizione avanzata dai mediatori americani. Il ritiro americano schiude inoltre le porte alla guerra civile: a nord tra sunniti e curdi (che puntano al controllo del petrolio) e a sud per l?egemonia politica della maggioranza sciita. Intanto la violenza non si placa, l?economia è in crisi nonostante la ricchezza petrolifera, la popolazione è fortemente disagiata (l?elettricità funziona solo qualche ora al giorno), la corruzione diffusa. Il ritardo nella formazione del governo non può così che lasciare spazio alle forze dell?eversione. Al Qaida ha messo a punto una strategia di rilancio per tornare ad operare in Iraq. L?organizzazione terroristica è a caccia di finanziamenti e mira a procurarseli gettando i suoi uomini nel racket contro le imprese commerciali e le compagnie petrolifere. Un secondo obiettivo è l?esercito iracheno, da attirare dalla propria parte là dove è possibile oppure da colpire con il massimo dell?efficacia. Terzo ed ultimo obiettivo di al Qaida è la riconquista della minoranza sunnita, che nei primi anni del conflitto aveva fornito ai terroristi ospitalità, ma che dopo l?arrivo del generale Petraeus si è opposta allo strapotere di al Qaida. Di fronte ci sono deboli strutture di difesa irachene. Forse esercito e polizia sono pronti a combattere l?eversione interna, ma certamente il Paese, allo stato attuale, non potrebbe resistere ad un attacco dall?esterno. C?è di più. Secondo Jean Sliman, arcivescovo latino di origine libanese, in Iraq dal 2001, «al cuore della violenza che si perpetua in Iraq sta il problema profondo dell?identità collettiva irachena: è scomparsa nella polvere la vecchia identità laica baathista, ma appare impossibile trovarne una sostitutiva che valga per tutti». Al contrario i rapporti tra le formazioni (e le milizie) sciite, sunnite e curde sono sempre sul punto di rottura. Gli sciiti occupano oggi la maggior parte dei posti di potere. I sunniti dal canto loro non riescono ad accettare di aver perso peso dopo secoli di predominio.Il pericolo è accresciuto dal fatto che a trarre i maggiori vantaggi dal caos iracheno sono i Paesi confinanti, primo fra tutti l?Iran. Il quale da una parte sta accrescendo il proprio ruolo regionale e dall?altra considera un punto a proprio vantaggio la caduta, prima in Afghanistan e poi in Iraq, di due regimi anti-iraniani: quello talebano e quello di Saddam, senza che in nessuno di questi due Paesi si sia ancora creata una nuova e valida organizzazione di potere. Al fine di espandere una propria zona di influenza, Teheran mira a sostenere un?alleanza fra le due principali fazioni sciite irachene: quella capeggiata dal primo ministro Nouri al-Maliki e l?Alleanza nazionale irachena, che raggruppa i seguaci del religioso e ferocemente anti-americano Muqtada Sadr e del Consiglio Supremo Islamico Iracheno. Riuscirà questa alleanza? C?è chi la vede improbabile se non per il fatto che, come sostiene la studiosa e collaboratrice del «Sole 24 Ore» Farian Sabahi, «difficilmente gli sciiti iracheni (arabi) fanno comunella con gli iraniani (non arabi ma indoeuropei): la guerra Iran-Iraq (1980-1988) ha già dimostrato che si sentono in primis arabi e sciiti solo in seconda battuta. Ed essendo legata alla vecchia leadership emigrata in Iran al tempo di Saddam, con il ricambio generazionale nei prossimi anni l?influenza di Teheran a Baghdad dovrebbe diminuire».Ma non è solo l?Iran a tenere gli occhi su Baghdad. C?è anche l?Arabia Saudita, guardiana del potere sunnita, egualmente decisa a tenere sotto controllo l?espansionismo sciita sostenendo la coalizione guidata dall?ex primo ministro Iyad Allawi, sciita laico appoggiato dai sunniti. Al nord c?è poi la Turchia, con l?irrisolta questione curda, che intende bloccare ogni rivendicazione di indipendenza da parte dei curdi iracheni, parte importante di ogni accordo a Baghdad. E a occidente c?è infine la Siria, alleata dell?Iran e rivale dell?Arabia Saudita sulla maggior parte delle questioni regionali, con piani ben precisi riguardo all?Iraq. Il regime baathista di Damasco appoggia infatti Allawi, il quale a sua volta gode del sostegno degli exbaathisti iracheni.Occorre infine considerare che l?Iraq è situato ad un crocevia strategico tra il mondo arabo e il resto dell?Asia, un punto di accesso alla regione per le potenze non arabe come la Turchia e l?Iran e un?area di difesa per l?Arabia Saudita e gli Stati del Golfo arabico. Con le terze maggiori riserve mondiali di petrolio, l?Iraq offre inoltre allettanti potenzialità di ricchezza. Tutti fattori che inducono i Paesi confinanti a far sì che l?Iraq diventi un alleato, e non un aggressore, come ai tempi di Saddam Hussein.
