Quegli strani territori nelle opere letterarie
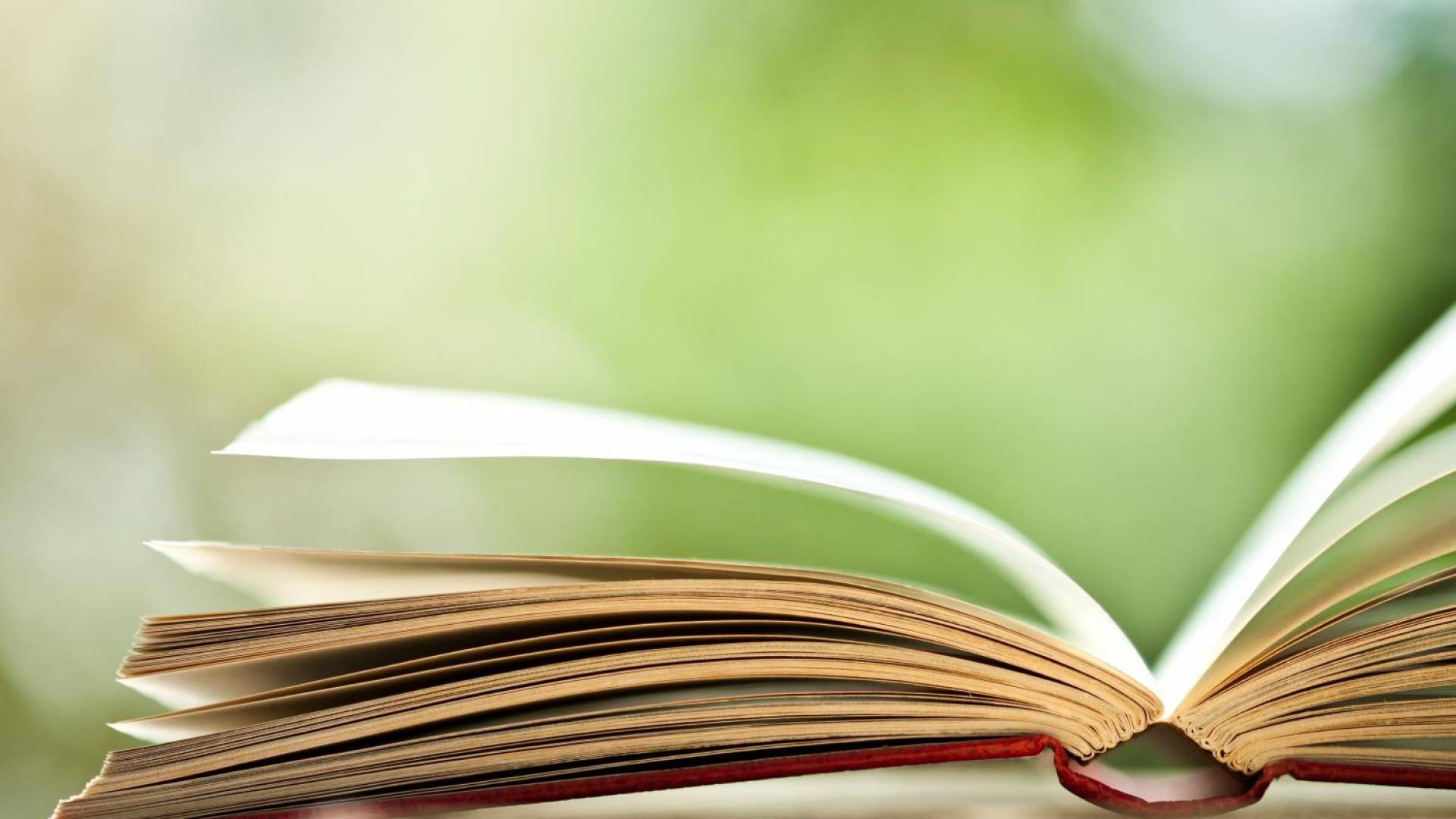
Nel 1987 uno dei più grandi semiologi e studiosi dei testi al mondo, ovvero Gérard Genette, scomparso poco più di tre anni fa, pubblicò un libro che si intitolava Soglie. In breve tempo Sogliedivenne un vero e proprio classico, a suo modo (la traduzione italiana è di Einaudi. Non è un romanzo, ma è un saggio particolare, perché esamina tutto quello che ha a che fare con un’opera letteraria, al di fuori dell’opera letteraria. Ovvero quello che gli specialisti chiamano il «paratesto». La spiegazione è semplice: paratesti sono tutte quelle cose che fanno parte del libro, ma non sono il libro. A cominciare dal titolo, che non è detto sia dell’autore. Continuando con le copertine, con le dediche, con i ringraziamenti, con le prefazioni, le scelte tipografiche. Il libro si intitola Soglie, perché esamina quello strano territorio tra il dentro del testo, ovvero quello che ha effettivamente scritto l’autore, e il fuori, ciò che esce dal testo, ne fa parte, ma non ne è parte. I lettori hanno a che fare di continuo con le soglie. Leggono le alette di copertina, le notizie sugli autori, guardano il titolo e decidono se gli piace oppure no. Poi aprono, e si trovano di fronte a dediche, a lunghi ringraziamenti verso persone di cui sanno poco o niente, si lasciano affascinare dal lettering e dal tipo di carta. Non ci si fa caso, ma i libri si presentano in questo modo, solo dopo viene il testo e i paratesti, spesso, non sono neppure autoriali, sono editoriali. A cominciare dal titolo: che assai raramente è deciso dall’autore. Se Genette fosse ancora vivo, scriverebbe probabilmente un seguito di Soglie, perché oggi le soglie sono ancora di più. Quasi sempre gli autori e gli editori usano dei nuovi paratesti che finiscono sui social network, nei video in Rete delle presentazioni, nelle fascette, nel lavoro di pubblicità e di promozione che si fa – sempre più massiccio – sui libri in uscita.
La moda dell’esergo
Perché parlo di Genette? Perché negli ultimi tempi, e in modo sempre più evidente, c’è un tipo di paratesto che impera ormai in tutti i romanzi, e non solo nei romanzi. E non parlo soltanto dei romanzi importanti, degli autori che chiameremmo letterari. Parlo anche di romanzi semplici, popolari, rivolti a un pubblico che non ha molte pretese e vuole semplicemente divertirsi. Mi riferisco a una cosa che in letteratura si chiama «esergo». L’esergo, detto in un altro modo, è la citazione iniziale a un romanzo. Si apre il libro, c’è il frontespizio, con autore, titolo ed editore. E poi può esserci l’esergo. E l’esergo è un ammiccare, è un far capire al lettore, è mettere una sottolineatura da qualche parte, per mandare dei messaggi. Si fa da sempre. Ma negli ultimi anni si fa moltissimo, direi troppo, e aggiungerei anche: in maniera esagerata. Perché tutti i libri devono iniziare con citazioni iniziali roboanti, eccessive, inspiegabili per il lettore? Faccio un esempio: l’altro giorno ho preso in mano in libreria l’opera prima di una nota blogger-influencer italiana. Un libro che vende moltissimo, e che è un romanzo. Un romanzo d’amore, certo, che non giudichiamo in questa sede, ma certamente un romanzo semplice, rivolto a un pubblico giovane, che è attratto da questo mondo di autori e autrici più famose sul web che nelle aule universitarie o nei convegni letterari. Niente di male. Ma che senso ha mettere in esergo al libro, una citazione dall’assai complesso e vertiginoso Frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes? Che nessuno dei lettori di questa autrice probabilmente andrà ad aprire in tutta la sua vita? Ma non è solo questo il caso. Se entrate in libreria e aprite uno a uno i romanzi di nuova uscita troverete florilegi continui: da Cervantes a Shakespeare, da Thomas Mann a Nietzsche (gettonatissimo), fino ai latini, ai greci, ai filosofi (Eraclito piace sempre), e persino i mistici orientali, i classici indiani o giapponesi.
Inutili puntelli
Non è un dettaglio. È un segno, avrebbe detto Genette. Una tendenza di questi anni. Per gli autori del Novecento, l’esergo non era così frequente, anzi. Lo è invece oggi quasi a compensare una mancanza, un indebolimento della qualità dei testi, come fosse una insicurezza. Come a puntellarsi con qualcosa di importante, di ben scritto, di assai profondo, e da subito, nel dubbio che dopo – come purtroppo quasi sempre accade – ci sia ben poco di profondo e di importante. La modesta proposta è ovviamente quella di fare un appello ai nuovi autori, agli editori. Chiedere di astenersi da mettere degli esergo nei libri, per qualche anno. Togliere questa esibizione di frammenti, presi spesso dal web e in qualche caso neppure verificati. E lasciare il testo nudo, senza suggestioni, senza aggiunte. A misurarsi da solo, e senza inutili aiuti, con il lettore.